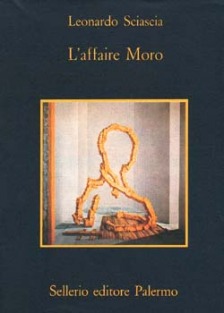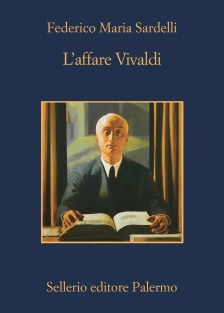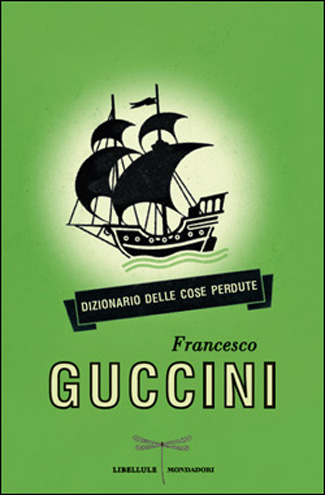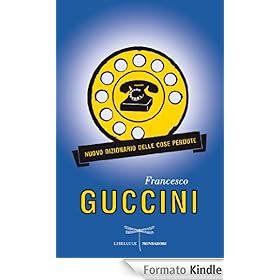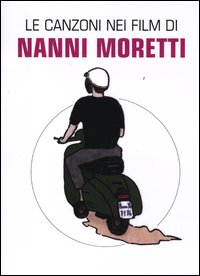Riccardo Bocca, Tutta un'altra strage, BUR, 2007, pp. 259, € 10,20
In 35 anni di storia, sono
stati scritti tanti libri sulla strage alla stazione di Bologna e forse questo
di Riccardo Bocca presuppone la
lettura di qualcuno di essi, cui si fa esplicito rimando. Tutta un'altra strage, quanto meno al momento della sua uscita (2007),
si poneva come punto della situazione e come momento di verifica delle verità
giudiziarie uscite da tanti anni di indagini (talvolta deviate a bella posta) e
processi. Bocca parla di molti dei
personaggi assurti ai ruoli di protagonisti e/o comprimari riguardo alla strage
del 2 agosto 1980, focalizzandosi sulle tre persone condannate in via definitiva
per la bomba, cioè Valerio Fioravanti,
Francesca Mambro (entrambi
condannati all'ergastolo) e Luigi Ciavardini
(che ha avuto trent'anni, in quanto minorenne all'epoca dei fatti). Ma ce ne
sono altri, magari usciti assolti da indagini e processi, come quel Sergio Picciafuoco che di sicuro si
trovava alla stazione ferroviaria di Bologna quella mattina del 2 agosto 1980. Altri
personaggi di quella stagione dell'eversione nera (e della storia italiana)
sono morti o scomparsi. Nessuno ha mai confessato le proprie responsabilità per
uno degli atti più barbari della storia stragista italiana (che pure non è
povera di atti orribili), per il quale qualcuno (sc. Licio Gelli) continua a sostenere che si sia trattato
dell'esplosione di una caldaia (in agosto, si badi bene). In questo senso, uno
degli obiettivi di Bocca è di
valutare la personalità criminale di Fioravanti
e della Mambro (da trent'anni coppia
anche per la legge italiana, essendosi sposati in carcere), in relazione alla
capacità morale di commettere un atto del quale si sono sempre dichiarati
innocenti. Dalla lettura del libro non si può che propendere per una tesi che
contrasta con quest'ultima affermazione dei condannati, in forza di molteplici
elementi, non ultimo il continuo variare degli alibi per il giorno della strage
e le versioni su questo punto assai poco credibili per degli innocenti. Che poi
i tre giovani condannati abbiano potuto fare tutto da soli è cosa che si può
mettere in dubbio, anche alla luce dei numerosi depistaggi successivi al 2
agosto 1980. Ma questa, come dice Bocca,
è tutta un'altra strage.